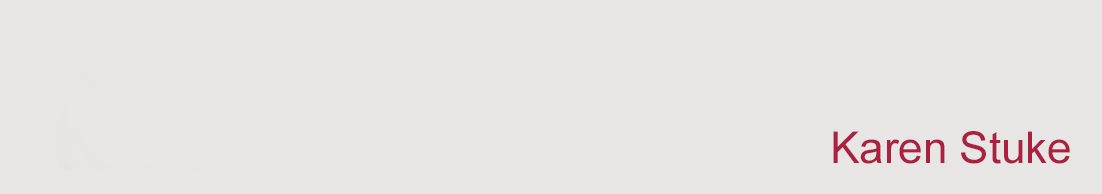di Sasha Taormina
Con ‚Hotel Bogotà- L’ultimo check-out‘, Karen Stuke racconta lo spirito mistico dell’albergo in cui sono passati Newton e Burri. La mostra è ospitata dal festival di fotografia del paesaggio a Castelnuovo di Porto.
Berlino 1911. Sulla Schlüterstraße 45, conosciuta oggi per essere una delle zone più eleganti e cosmopolite della città, ha avuto inizio la storia di un edificio che è rimasto legato all’arte e alla cultura berlinesi fino ad oggi. La casa di cui parliamo era un luogo di incontro per aristocratici e business men, dove poter discutere e organizzare feste sontuose. È proprio qui che negli anni Trenta la fotografa di moda YVA (pseudonimo di Else Ernestine Neuländer-Simon) ha vissuto e ha preso con sé l’allora apprendista Helmut Newton, prima di essere deportata e assassinata dai nazisti durante la seconda guerra mondiale. In seguito, il regime tedesco ha rilevato la proprietà a Charlottenburg, utilizzandola come Camera della Cultura del Reich fino al 1945. Dopo la fine della guerra, vi sono state esposte le opere bandite dal regime.

Nel 1964, al quarto e quinto piano dell’edificio è stato aperto l’Hotel Bogotà, dal nome della capitale colombiana che ha accolto il proprietario dell’Hotel durante le persecuzioni naziste. Da quel momento in poi, all’interno delle stanze hanno alloggiato tanti artisti, da Renè Burri a Helmut Newton, giusto per citarne due, e l’Hotel è diventato un sito di importante testimonianza dei cambiamenti culturali e politici nella capitale tedesca fino all’arrivo del nuovo millennio. Joachim Rissman, l’ultimo direttore, grande appassionato di arte, ha curato una serie di mostre presso l’Hotel e organizzato serate a ritmo di swing. Negli anni, tutte le pareti del Bogotà – passando dai corridoi per finire all’atrio – sono sempre state riempite di fotografie di ogni formato. Una fusione artistica che è stata definita dal direttore stesso Photo Square.

La fotografa tedesca Karen Stuke è arrivata all’Hotel Bogotà nel 2012 e, colpita dal fascino classico e storico della struttura, ha iniziato a scattare all’interno di quelle camere; di certo non sapeva ancora che nel 2013 l’Hotel sarebbe stato costretto a chiudere i battenti per questioni di difficoltà economica. È stato proprio Rissman a permettere alla Stuke di pernottare in Hotel e di aggirarsi al suo interno per portare avanti la ricerca artistica. Quarantacinque camere, una diversa a notte, dove poter cogliere lo spirito “mistico” dell’Hotel fino all’ultimo check-out, quando il giorno della vigilia di Natale del 2013, dall’Hotel partì l’ultimo pacco con le 105 chiavi delle stanze.

Gli scatti di Karen Stuke si rivelano malinconici, ma ricchi di colori vibranti. Le immagini fluttuanti ed eteree, racchiudono i letti e i dettagli delle camere rappresentando le fasi rem più recondite. Grazie all’uso della fotocamera a foro stenopeico e ai lunghi tempi di esposizione, che in realtà in questo caso coincidono con la durata di ogni pernottamento, le fotografie riflettono l’essenza di quell’atmosfera tra il reale e il subconscio. Il sonno prende vita e si distacca, si scioglie, si fonde, confondendosi con la luce; la fotografa ne è testimone, sdoppiando la sua anima all’Enter The Void e custodendo la notte con la sua scatola di legno. Le dissolvenze e i contrasti delle camere del Bogotà viste dall’occhio della Stuke, catapultano lo spettatore in una dimensione di semi lucidità lynchiana e onirica: «Come se fossi immersa in un sogno bellissimo e allo stesso tempo in un terribile incubo» diceva Donna Hayward in Twin Peaks. Un incrocio tra il fantastico e, in questo caso, il nostalgico.

Ma l’atmosfera art nuveau e una buona dose di romanticismo, sia nella storia del Bogotà che nel lavoro di narrazione fotografica della Stuke, possono essere legate ad alcune peculiarità del regista Wes Anderson e del suo Grand Budapest Hotel, ambientato nell’Europa del XX secolo. Per la pellicola, visionaria tanto quanto piena di riferimenti alla realtà, Anderson si ispirò alla figura di Stefan Zweig, scrittore austriaco tra i più noti tra gli anni Venti e Trenta le cui opere sono state bruciate dai nazisti. Così come la storia del protagonista del film, il tuttofare lobby boy perennemente perseguitato, per un motivo o per un altro, anche a causa dei suoi tratti somatici. Il film, come nelle stanze del Bogotà, si svolge principalmente all’interno dell’hotel ed è abitato da una serie di personaggi che lo animano con le proprie avventure. Entrambi gli hotel sono accomunati da una luce calda e diffusa, dove il colore determina le immagini, finte o reali che siano.

Seguendo i salti temporali alla Wes Anderson ritorniamo nel 2013, anno in cui a causa di pressioni economiche, le porte del Bogotà si sono chiuse definitivamente. Nonostante i tentativi anche da parte di molti artisti di preservare un polo culturale di grande rilievo storico-artistico – Bogota darf nicht sterben! (Bogotà non deve morire) – l’edificio è stato venduto e gran parte della mobilia messa all’asta. Oggi sulla Schlüterstraße 45 rimane il vecchio baldacchino di un lontano ricordo, una vecchia casa dove si respira ancora la storia passata. E le fotografie di Karen Stuke sono probabilmente tra le ultime testimonianze della vita all’interno del Hotel Bogotà in cui, oltre a evincersi la bellezza e il fascino di quelle camere, è incluso un velo di malinconia. Del resto, come diceva Helmut Newton nel 2002, «Sie schlafen in heiligen Räumen». Dormono in spazi sacri.
Sasha Taormina, Rolling Stone Italy, 7. October 2020